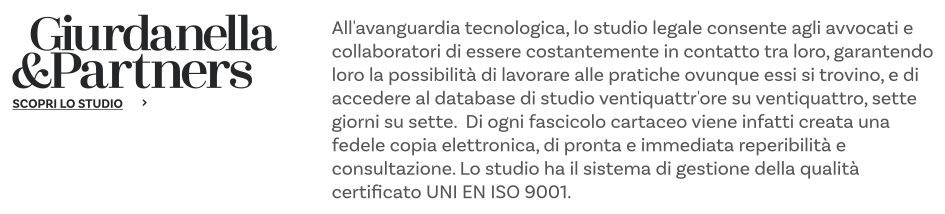Il Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1556 del 15 settembre 2025 ha fornito un’interpretazione puntuale e dettagliata del percorso che le Amministrazioni debbono sviluppare in base all’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 qualora intendano affidare servizi (pubblici e strumentali) mediante il modello dell’in house providing, evidenziando come lo stesso sia uno dei moduli possibili di auto-organizzazione e non sia subordinato alla dimostrazione del c.d. “fallimento del mercato”.
La pronunzia merita di essere analizzata in dettaglio, poiché presenta nelle sue motivazioni anche un significativo approfondimento sui profili distintivi tra servizi pubblici e servizi strumentali.
1. Contestualizzazione.
La sentenza riguarda un contenzioso instaurato da un operatore specializzato nel settore della riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, concessionario uscente del servizio di riscossione del Canone Unico Patrimoniale, contro la decisione del Comune concedente di affidare in house lo stesso servizio a una società dal medesimo ente partecipata (unitamente ad altri enti locali) e costituita per la gestione della riscossione delle entrate derivanti da tributi e canoni.
Il Comune ha qualificato il servizio come strumentale e, nel solco di quanto previsto dall’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, ha effettuato la verifica di congruità (mediante un’indagine “sul” mercato di riferimento, che ha preso in esame affidamenti recenti per lo stesso servizio) e degli altri benefici determinati dalla scelta dell’in house (derivati dal progetto presentato dalla società partecipata potenziale affidataria).
Il precedente concessionario (uscente) del servizio ha contestato l’affidamento in house, evidenziando in particolare tre elementi:
a) l’insufficienza della c.d. “motivazione rafforzata” in relazione al mancato ricorso al mercato (omessa esplicazione dei vantaggi del modello in house rispetto alle procedure ad evidenza pubblica);
b) il limitato numero (sette) delle gare prese in esame dal Comune nell’indagine “sul” mercato di riferimento;
c) l’ermetica specificazione dei vantaggi per la collettività.
2. Qualificazione del servizio di riscossione (anche coattiva) del Canone unico patrimoniale.
La sentenza, analizzando la qualificazione conferita al servizio oggetto dell’affidamento in house, costituito dalle attività di riscossione (anche coattiva) del Canone Unico Patrimoniale del Comune, valida la definizione dello stesso come servizio strumentale, estendendola al più ampio quadro dei servizi di riscossione.
I giudici amministrativi rilevano infatti come il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali sia un servizio strumentale al Comune, poiché l’attività in cui si concretizza il servizio non è diretta a soddisfare in via immediata le esigenze della collettività, bensì è rivolta esclusivamente a favore dell’amministrazione, in quanto è finalizzata a recuperare le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.
La pronunzia evidenzia come, in sostanza, nel servizio di riscossione (anche coattiva) di un’entrata manchi l’elemento funzionale che caratterizza i servizi pubblici locali, rinvenibile nel soddisfacimento diretto dei bisogni di interesse generale.
L’analisi condotta nella sentenza è, con riferimento ai servizi di riscossione delle entrate, chiaramente esplicativa dell’applicazione necessaria del parametro fondamentale per la qualificazione di un’attività come servizio pubblico o strumentale, ossia il soddisfacimento in via diretta o meno delle esigenze della collettività.
Tale declaratoria costituisce importante affermazione della valenza del parametro per l’individuazione, da parte degli enti locali, dei servizi pubblici e di quelli strumentali, risultando tale passaggio fondamentale per la riconduzione dei primi agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 201/2022 (si pensi alla relazione sull’andamento gestionale prevista dall’art. 30 del decreto).
Correlativamente, la ponderata applicazione del parametro consente di ricondurre i servizi qualificati come strumentali a una gestione per alcuni aspetti più facilitata (non sono soggetti, per esempio, agli obblighi di pubblicazione sulla Piattaforma per la trasparenza dei SPL), pur risultando comunque rilevante il controllo sul loro andamento gestionale nella logica della dimostrazione dell’efficienza del modello organizzativo adottato.
3. Sequenza per la definizione del modello organizzativo e per l’affidamento in house.
Pur non riportando elementi di commento o di analisi specifica, in un passaggio la sentenza evidenzia la sequenza sostanziale adottata dal Comune, che si articola:
a) nella formalizzazione, mediante delibera del Consiglio comunale, del modello organizzativo prescelto (l’in house), con il supporto motivazionale specifico della relazione illustrativa e con evidenziazione dell’assetto prestazionale (con il contratto di servizio);
b) nel successivo “perfezionamento” dell’affidamento, mediante determinazione dirigenziale.
La pronunzia si pone in linea con altri interventi recenti, che evidenziano la riconduzione della scelta del “modello macro-organizzativo” alle competenze dell’organo consiliare, sia per l’espressa previsione con riferimento ai servizi pubblici sancita dall’art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 (“organizzazione dei pubblici servizi…”) sia per le implicazioni che il modello organizzativo ha per i servizi strumentali in una proiezione di media-lunga durata (si pensi alla portata degli effetti economici su base pluriennale superiore al triennio, che comportano il passaggio necessario in funzione di quanto stabilito dal medesimo art. 42, comma 2 del Tuel alla lettera i).
4. Schema del modello organizzativo “in house”.
Proprio la scelta dell’affidamento in house come modello organizzativo per il servizio strumentale di riscossione del canone unico patrimoniale costituisce il fulcro della sentenza, in rapporto a quanto previsto dall’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, ma afferendo anche alla valutazione delle opzioni tra i tre macro-moduli delinearti nel comma 1 della stessa norma (esternalizzazione-ricorso al mercato, autoproduzione-in house, cooperazione istituzionale con altre Amministrazioni).
La disposizione prevede che:
a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3;
b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
c) in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;
d) i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
Il Tar Veneto evidenzia come la lettera della disposizione normativa è chiara nell’escludere che l’affidamento in house sia un modello subordinato rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, ritenendolo invece alternativo a quest’ultimo, discostandosi da quanto previsto dall’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2026 (che chiedeva alle stazioni appaltanti di dar conto “nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato”).
La pronunzia, a sostegno, richiama la relazione illustrativa allo schema di decreto che è poi divenuto il nuovo Codice dei contratti pubblici, rilevando che in riferimento all’art. 7 tale documento evidenzia che “la codificazione del principio [di auto-organizzazione amministrativa] determina un maggiore allineamento del diritto nazionale all’ordinamento dell’Unione, che pone l’autoproduzione e l’esternalizzazione su un piano di tendenziale parità, così superando l’opzione fortemente restrittiva del d.lgs. n. 50/2016”.
Rispetto a tale indicazione, i giudici amministrativi precisano che l’alternatività tra l’affidamento in house e il ricorso al mercato è soltanto tendenziale in quanto la scelta per l’auto-organizzazione richiede pur sempre una motivazione (ancorché non più rafforzata), a differenza di quanto accade per l’esternalizzazione. Essa, tuttavia, rispetto alla precedente disciplina, non ricomprende più la dimostrazione del “fallimento del mercato”, ma soltanto la valutazione della congruità economica dell’offerta.
Su questo punto si innestano necessariamente tre considerazioni.
In primo luogo, risulta evidente, nell’interpretazione dei giudici amministrativi, che le previsioni contenute nell’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 richiedono all’Amministrazione di esplicitare il processo dimostrativo della congruità economica nel quadro di una più ampia analisi, illustrativa di altre due macro-componenti determinanti per la scelta del modello organizzativo, ossia i vantaggi per la collettività e le connesse esternalità.
Tali tre elementi devono essere esplicati nella loro portata specifica, ma devono essere illustrati anche i loro effetti in chiave di funzionalizzazione rispetto agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche che devono caratterizzare l’affidamento del servizio.
Peraltro, per i servizi strumentali la disposizione configura un percorso “facilitato”, in quanto stabilisce che il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici, fornendo correlativamente una schematizzazione del processo comparativo minimo (standard Consip o in mancanza standard di mercato).
Sia nella prefigurazione a portata generale della disposizione sia in quella dedicata ai servizi strumentali la valutazione dell’affidamento in house è riferita alla congruità (come, del resto, nell’art. 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2026) e all’economicità.
Nella sentenza emerge una linea interpretativa per cui le due funzionalizzazioni non richiedono necessariamente la dimostrazione della maggior convenienza del modello di autoproduzione rispetto ai soli valori di costo del servizio rilevabili nel mercato, ma piuttosto inducono a formulare una valutazione esplicativa della coerenza della soluzione con i dati desumibili dalle dinamiche concorrenziali nel settore di riferimento sul piano del valore e della resa delle prestazioni, con rilevazione della “convenienza economica” complessiva dell’operazione misurata in un confronto sulla base del rapporto qualità-prezzo.
Un secondo profilo di analisi necessaria riguarda la verifica delle esternalità connesse all’affidamento.
L’esternalità è l’influenza (positiva o negativa) che l’attività di un soggetto esercita, al di fuori delle transazioni di mercato, sul benessere o sulla produzione di un altro soggetto.
La verifica richiesta dall’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 deve pertanto essere preordinata ad evidenziare le esternalità della scelta del modulo in house, tenendo in particolare considerazione il valore sociale e il costo sociale delle stesse, connettendosi quindi inevitabilmente con l’analisi dei vantaggi per la collettività.
Un terzo aspetto particolare di analisi deve riportarsi al raccordo tra le previsioni dell’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e quelle, di poco precedenti, dell’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022, ossia la disciplina di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Il Tar Veneto, con riferimento all’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, delinea per la norma una portata applicativa generale, riferita a tutte le tipologie di attività che possono rientrare nella logica dell’autoproduzione.
La sentenza, infatti, precisa che “la nuova disciplina prevede due livelli di complessità della motivazione, in base all’oggetto del contratto: per i servizi pubblici locali (rivolti all’utenza) è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse; per i servizi strumentali all’amministrazione è invece sufficiente una motivazione più snella che dia conto dei vantaggi in termini di economicità celerità e perseguimento degli interessi strategici, anche sulla scorta di parametri di confronto oggettivi e predeterminati”.
Tuttavia si deve rilevare come l’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022 determini come condizione essenziale per l’affidamento del servizio (pubblico locale con rilevanza economica) una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando (…) i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo:
a) agli investimenti,
b) alla qualità del servizio,
c) ai costi dei servizi per gli utenti,
d) all’impatto sulla finanza pubblica,
e) agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi.
Tale valutazione deve prendere in considerazione anche i risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche sull’andamento gestionale (che le Amministrazioni devono definire ogni anno in base all’art. 30 dello stesso d.lgs. n. 201/2022).
L’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022 finalizza esplicitamente la verifica (e la sua traduzione nella motivazione rafforzata della delibera che definisce il modello organizzativo) all’evidenziazione delle ragioni del “mancato ricorso al mercato” (riprendendo la definizione contenuta nell’art. 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016), evidenziando l’alternatività tra l’in house e la gara ad evidenza pubblica.
Tuttavia, il particolare dato normativo fornisce un macro-obiettivo per la verifica, poiché correla la dimostrazione della scelta dell’in house a una necessaria finalizzazione all’efficiente gestione del servizio, che viene ad essere a sua volta ricondotta a una misurazione da elaborare con riferimento a un set di parametri ad ampio spettro, nei quali si combinano sia elementi economici sia elementi qualitativi.
L’esame degli aspetti economici non è, peraltro, ristretto al confronto dei costi di produzione del servizio, ma richiede specifico approfondimento in merito:
a) alle capacità di investimento del potenziale affidatario;
b) all’impatto complessivo sulle dinamiche di finanza pubblica (dovendo quindi considerare non solo le componenti di costo, ma anche le potenzialità in rapporto ai ricavi e l’efficienza nella gestione dei flussi produttivi degli stessi);
c) alle ricadute sugli utenti, sia in termini di costi (diretti, come quelli tariffari, e indiretti) sia di condizioni di fruizione dei servizi.
E’ su quest’ultimo versante che le proiezioni operative dell’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022 si sovrappongono, dando rilevanza a un fattore decisivo per la verifica: l’analisi dei benefici per la collettività, che può risultare decisiva per la scelta dell’in house e che, pertanto, deve essere compiutamente dimostrata.
5. Dimostrazione della convenienza economica dell’affidamento in house.
La sentenza focalizza l’attenzione (essendo peraltro dato critico del contenzioso esaminato) sul processo di elaborazione della verifica della congruità dell’affidamento in house, chiarendone alcuni aspetti rilevanti in chiave metodologica.
La fase necessaria, per gli affidamenti di servizi strumentali, è la definizione del quadro di benchmark, che deve partire dall’analisi delle Convenzioni Consip e delle convenzioni-quadro stipulate da altri soggetti aggregatori, nonché degli standard eventualmente definiti da altri enti (potendo in tale quadro assumere a riferimento sia le Autorità di regolazione, sia l’Anac, sia ancora organismi istituzionali qualificati produttori di standard per i servizi oggetto dell’affidamento).
In caso di impossibilità per assenza di convenzioni in essere o di altri strumenti derivanti da soggetti istituzionali, l’elemento-chiave del processo, ossia il confronto con le dinamiche di mercato, deve essere ricondotto all’enucleazione degli standard di mercato: per tale operazione le Amministrazioni hanno massima autonomia di scelta sulle metodologie elaborative e sulla definizione dei campioni (come peraltro era stato evidenziato dalla giurisprudenza in ordine agli aspetti attuativi dell’art. 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016).
Posta la discrezionalità nella scelta del metodo, il Tar Veneto evidenzia però la necessità che la comparazione sia effettuata con affidamenti del medesimo servizio o che, comunque, si avvicinino allo stesso per le modalità produttive, dovendo le Amministrazioni privilegiare un’azione comparativa su elementi il più possibile tra loro raffrontabili rispetto a un’analisi condotta su un campione magari quantitativamente più rilevante, ma meno coerente negli aspetti descrittivi dell’attività.
6. Dimostrazione dei benefici ulteriori.
La sentenza delinea infine la rilevanza sostanziale della seconda macro-componente oggettiva della verifica, ossia quella inerente ai benefici per la collettività.
Su tale versante, uno dei profili di maggior interesse della pronunzia rileva nell’evidenziazione della “traduzione concreta” di tali benefici, nel momento in cui essi rappresentino dei vantaggi in termini di economicità (quindi minori costi in chiave di gestione complessiva) e di perseguimento di interessi strategici (quindi con proiezione di possibili effetti positivi per le dinamiche economico-finanziarie del servizio e dell’ente in un quadro temporale di medio-lungo periodo).
In simile prospettiva possono rilevare diversi fattori, dei quali, afferendo al caso, il Tar Veneto evidenzia la portata potenziale in termini di beneficio, come:
a) la resa di prestazioni aggiuntive o complementari rispetto al servizio non oggetto di specifica remunerazione e rese possibili per il potenziale affidatario in house da sinergie con proprie attività tipiche già consolidate (es. campagne di informazione per i cittadini, implementazione di soluzioni web-app già affinate, ecc.);
b) le efficienze derivanti da gestioni digitalizzate di varie attività relative al servizio, con evidenziazione anche di maggiori vantaggi nel coordinamento con l’ente affidante.
Dalla pronunzia del Tar Veneto anche per tali elementi si rileva una connotazione metodologica molto importante: l’esplicitazione dei vantaggi deve essere declinata in termini illustrativi dettagliati, tali da assicurare l’evidenza di ogni beneficio e il relativo impatto (anche con modulazioni previsionali potenziali).