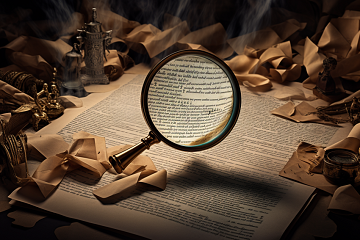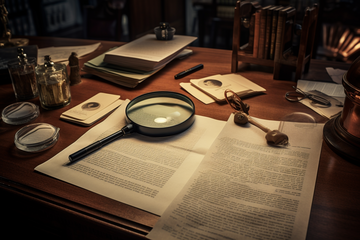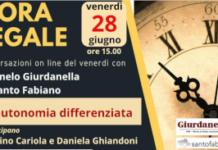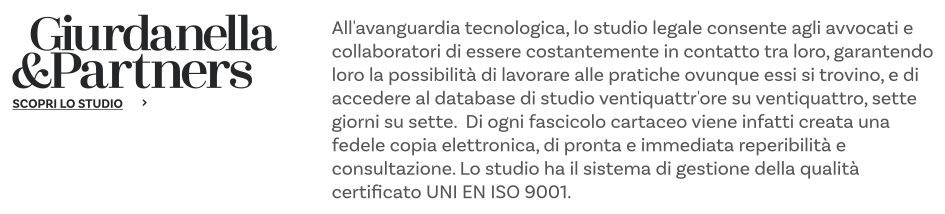È stata definita dalla Corte Costituzionale, con sentenza 88/2025 (redattore Filippo Patroni Griffi) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 nella parte in cui prevede un limite temporale all’esercizio della potestà di annullamento in autotutela rispetto ad atti adottati nella tutela dei beni culturali (l’aveva sollevata il Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva della sesta sezione n. 8296/2024; ne avevamo parlato qui).
In breve, il Consiglio di Stato dubitava della legittimità dell’art. 21-nonies in quanto la “tagliola” del termine massimo per annullare in autotutela valeva anche per i provvedimenti adottati a tutela dei beni culturali.
Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione della conformità di tale disposizione agli articoli 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. quest’ultimo con riferimento agli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 (ratificata dall’Italia con l. 133/2020).
Ha notato pure la contraddizione fra il trattamento uniforme riservato dall’art. 21-nonies agli interessi pubblici culturali rispetto agli altri varie altre disposizioni della l. 241/1990 che – appunto con riferimento a tale tutela – sacrificano l’interesse del privato alla rapida conclusione del procedimento
Con la sentenza n. 88 del 26/6/2025 la Corte Costituzionale ha innanzitutto dichiarato inammissibile la censura sollevata con riferimento alla normativa interposta della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa perché la relativa censura “è priva di qualsiasi illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato”.
Riguardo agli altri parametri costituzionali sollevati dal Consiglio di Stato, la sentenza della Corte ripercorre l’evoluzione dell’istituto dell’annullamento in autotutela, giungendo alle conclusioni generali che:
“Il potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta ‘supremazia’ (salvi i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua ‘inesauribilità’, nel suo ancoraggio costituzionale è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale (art. 98 Cost.)”;
“Il riesame del provvedimento, pur mosso da ragioni di legittimità, non costituisce espressione di quel potere già esercitato, bensì di un altro potere riconosciuto in via generale all’amministrazione, quello dell’annullamento d’ufficio, che, proprio perché diverso da quello esercitato e su cui va a incidere, è assoggettata a regole specifiche, quanto a presupposti, a disciplina procedimentale e a portata della discrezionalità di cui la funzione di autotutela è espressione”.
Allora – prosegue la Corte – è razionale che nell’esercizio di tale nuovo potere siano tenute ferme le garanzie procedimentali a tutela degli altri interessi coinvolti.
Per quanto riguarda specificamente le esigenze di tutela dei beni culturali, la sentenza in esame rileva che esse sono già tutelate da diverse disposizioni sull’esportazione di tali beni.
Se l’Amministrazione – come nel caso da cui è scaturita la questione di legittimità costituzionale – si avvede che il provvedimento di autorizzazione all’esportazione sia illegittimo, gioca il fattore tempo.
La limitazione temporale all’esercizio della potestà di annullamento in autotutela “risponde ragionevolmente alla scelta che, al fluire di un congruo tempo predeterminato, abbiano automatica prevalenza altri interessi di rilievo costituzionale. In particolare, dunque, sia la posizione di ‘matrice individuale’ dell’affidamento del destinatario del provvedimento favorevole, sia simultaneamente l’interesse di ‘matrice collettiva’ alla certezza e alla stabilità dei rapporti giuridici pubblici”.
Insomma – e qui secondo me si viene al cuore dell’argomentazione – “L’opzione invocata di inoperatività del termine finale fisso per l’esercizio del potere di annullamento dei provvedimenti autorizzatori potrebbe generare una situazione di incertezza nella vita dei cittadini e delle imprese idonea a incidere negativamente, in un’ottica più complessiva, sulle dinamiche del mercato (come nella specie su quello dell’arte) e sulla fiducia degli investitori: in definitiva, sull’affidabilità del ‘sistema Paese’”.
In definitiva, nello scontro tra l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale collettivo e quello mercantilistico privato prevale il secondo, che è funzionale alla garanzia dell’affidabilità dello Stato verso i “mercati”.