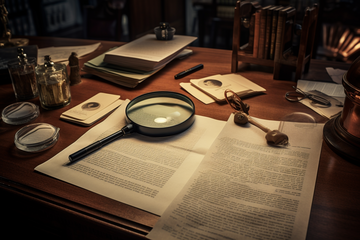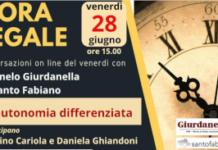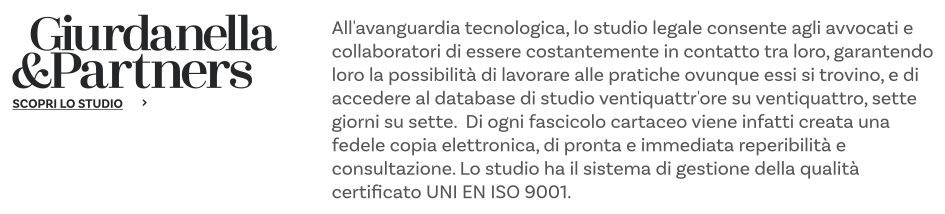È stata sollevata dal Consiglio di Stato un’interessante questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 nella parte in cui prevede un limite temporale all’esercizio della potestà di annullamento in autotutela rispetto ad atti adottati nella tutela dei beni culturali (sentenza non definitiva della Sesta sezione n. 8296/2024, reperibile qui)
Sul tempo dell’annullamento in autotutela si affrontano due interessi: quello pubblico alla tutela dei beni pubblici lesi dall’atto illegittimo; quello del privato, destinatario dell’atto da annullare, di affidamento sulla stabilità della situazione.
Secondo la giurisprudenza consolidata l’autoannullamento poteva intervenire a distanza di un tempo indefinito purché l’Amministrazione tenesse conto dei contrapposti interessi, per giudicare prevalente quello pubblico anche in confronto al consolidamento nel tempo della posizione del privato, e ne desse conto nella motivazione dell’atto di annullamento.
Fino al 2005 neanche la legge n. 241/1990 aveva disciplinato l’esercizio della potestà di annullamento in autotutela.
La legge n. 15/2005 introdusse, tra l’altro, l’art. 21-nonies ma prevedendo che l’annullamento fosse disposto “entro un termine ragionevole”, così sostanzialmente recependo l’orientamento giurisprudenziale sopra citato.
La legge n. 124/2015 previde il limite dell’annullamento “entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.
Il termine non valeva se i provvedimenti fossero stati ottenuti mediante false rappresentazioni dei fatti o atti e dichiarazioni falsi.
Non si è mai dubitato che il termine così fissato fosse perentorio.
Il decreto-legge n. 77/2021 convertito dalla l. n. 108/2021 – nell’ambito della normativa di accelerazione e di semplificazione dell’attività amministrativa per l’attuazione del PNRR – ha ridotto il termine a dodici mesi.
Il Consiglio di Stato si è appunto confrontato con questa normativa.
Il caso era di un’autorizzazione alla libera circolazione di un quadro, che era stata rilasciata da una Soprintendenza locale e poi annullata da una Direzione generale del Ministero della Cultura, dopo sei anni dal rilascio, quando un esperto aveva definitivamente attribuito l’opera al Vasari, ciò che ne aveva dimostrato il valore artistico e storico.
Il Consiglio di Stato ha escluso che l’autorizzazione fosse stata ottenuta attraverso una dichiarazione falsa perché quella resa dal proprietario alla Soprintendenza era semmai incompleta, senza che vi fosse l’obbligo di completarla; e comunque l’ambiguità non era oggettivamente imputabile a mala fede “potendo trattarsi di mere circostanze casuali”.
Non essendo certa la malafede del privato, è applicabile il vincolo temporale per l’esercizio della potestà di annullamento, trattandosi appunto di un’autorizzazione cioè di una delle due categorie di atti per i quali l’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 lo prevede.
Il Consiglio di Stato dubita della conformità di tale disposizione agli articoli 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. quest’ultimo con riferimento agli artt. 1, lett. b) e d), e 5 lett. a) e c) della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 (ratificata dall’Italia con l. n. 133/2020).
La soluzione della decadenza – osserva il Consiglio di Stato – “non solo tradisce il modello del continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi, delineato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 85 del 2013), ma preclude in maniera del tutto irragionevole la ricerca di un punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, tra gli stessi, compromettendo il perseguimento dell’obiettivo di tutela del bene ex art. 9, comma 2 Cost. che si pone la Repubblica e vulnerando, al contempo, il buon andamento dell’amministrazione ex art. 97, comma 2, Cost.”.
La questione di legittimità costituzionale della disposizione è posta solo “nella parte in cui, a fronte di un provvedimento a carattere autorizzativo (quale, nel caso di specie, l’attestato di libera circolazione di un’opera) ma incidente su un interesse sensibile e di rango costituzionale come la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, prevede, per l’adozione del provvedimento di annullamento, il rispetto di un limite temporale fisso di dodici mesi (e non, invece, il rispetto del termine flessibile ‘ragionevole’ previsto in generale dalla medesima disposizione)”.
Come accennato, l’evoluzione normativa più recente ha tutelato l’interesse del privato all’affidamento nell’ambito della più generale tendenza a privilegiare le esigenze dell’imprenditoria e dell’attività economica private rispetto agli interessi pubblici per così dire tradizionali.
Ma – aggiunge il Consiglio di Stato – l’affidamento privato non è un valore assoluto neanche nell’ambito dell’ordinamento eurounitario (di maggior “prestigio” rispetto a quello nazionale– si può qui aggiungere – a causa del consolidato un atteggiamento di deferenza verso di esso).
“E, infatti, sono gli stessi giudici di Lussemburgo a professare un’applicazione elastica del principio in parola, scevra da ogni automatismo, attenta al caso concreto e che passa per il bilanciamento con altri valori”.
Molto interessante è il rilievo della contraddizione che la sentenza coglie nel sistema della l. n. 241/1990 tra la decadenza fissata dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 nella tutela dei beni culturali (e ambientali), rispetto a tutte le altre disposizioni che – appunto con riferimento a tale tutela – sacrificano l’interesse del privato alla rapida conclusione del procedimento.
Si tratta degli articoli: 20, comma 4, sul silenzio-assenso che non si applica ai procedimenti su tali beni; 19, comma 1, sulla s.c.i.a. che pure non si applica; 14-ter sulla conferenza dei servizi nella quale il silenzio dell’Amministrazione preposta ai beni culturali non equivale ad assenso; 14-quinquies che prevede specifici rimedi avverso la determinazione conclusiva della stessa in favore delle amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela dei beni culturali.
In quei casi, insomma, il decorso del tempo non consolida la posizione del privato.
Dall’annullamento della disposizione dell’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 nei termini prospettati dalla sentenza del Consiglio di Stato, quindi con una decisione cosiddetta manipolatoria, deriverebbe che il limite temporale rimarrebbe ma non più verso autorizzazioni che incidono sulla circolazione dei beni culturali.