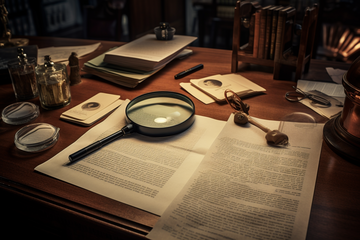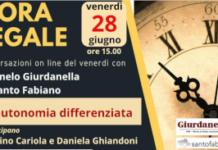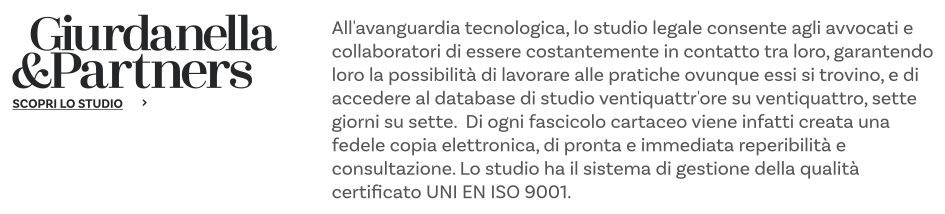Nel febbraio scorso avevamo commentato l’iniziativa del Prof. Luigi Ferrajoli di istituire un demanio spaziale in modo che lo spazio fosse equamente distribuito nell’interesse pubblico, evitando che se ne approprino soggetti privati (ovvio riferimento all’impresa SpaceX di E. Musk).
E’ successivamente entrata in vigore, il 25 giugno scorso, la legge 89/2025, in materia di economia dello spazio.
La normativa nazionale sopravvenuta ha riguardo sì alle attività spaziali, ma disciplina quelle che si svolgono a terra, cioè nei luoghi nei quali vige la sovranità nazionale (l’auspicio del Prof. Ferrajoli potrebbe in effetti essere attuato solo a un livello sovranazionale).
All’art. 2, la definizione di “attività spaziale” si estende anche a “l’esplorazione, l’estrazione e l’uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale”.
La legge, quindi, concerne tutte le attività a terra, comunque funzionali a qualsiasi modo di agire nello spazio.
Il titolo II disciplina l’esercizio delle attività spaziali condotte sul territorio italiano ma anche da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.
L’art. 5 individua i requisiti specifici per l’autorizzazione, in sintesi la capacità dell’operatore richiedente di garantire la sicurezza di tutta l’attività nonché la protezione rispetto all’inquinamento elettromagnetico e contro la perdita di dati.
Significativo del clima attuale è l’art. 7, comma 8, che vieta il rilascio dell’autorizzazione se l’esercizio dell’attività spaziale è suscettibile di nuocere alla difesa, alla sicurezza nazionale e alla “continuità delle relazioni internazionali”; ma anche “se sussistano legami tra l’operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell’Unione europea, non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegate”.
Le formule usate sono così ampie e generiche, da lasciare all’Amministrazione competente un campo di discrezionalità pressoché illimitato, in quanto collegato a valutazioni di politica estera.
Si potrebbe azzardare che viene così configurato un atto politico, con tutte le conseguenze sulla preclusione a qualsiasi tutela giurisdizionale.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato l’atto politico ha due requisiti:
-uno soggettivo, in quanto proviene da un organo preposto all’indirizzo e alla direzione della cosa pubblica al massimo livello;
-il secondo a carattere oggettivo, consistente nell’essere l’atto libero nei fini perché riconducibile alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri.
La decisione in merito compete all’”Autorità responsabile” (art. 7, comma 7) che è, secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera b): “il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128”.
A propria volta, l’art. 21, comma 2, d. lgs. 128/2003 individua quell’autorità come: “il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali”.
Per quanto l’autorizzazione in discorso non provenga direttamente dal Governo, l’esercizio della relativa potestà manifesta definitivamente la scelta conseguente alla collocazione internazionale dell’Italia e alla configurazione concreta della politica estera: così si fondono i due requisiti dell’atto politico.
L’art. 11 attribuisce all’Agenzia spaziale italiana la funzione di autorità di vigilanza sull’attività autorizzata sentiti anche “gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124”.
L’art. 14 costituisce la stessa Agenzia come “unica autorità di settore per la regolazione tecnica”.
Il titolo III disciplina l’immatricolazione degli oggetti spaziali rispetto ai quali l’Italia risulta Stato di lancio, e la conseguente istituzione di un Registro nazionale.
Il titolo IV disciplina la responsabilità civile per i danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte.
Responsabile è ovviamente l’operatore per i danni causati sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo (art. 18).
Nei casi in cui lo Stato italiano è responsabile diretto verso i terzi in applicazione di convenzioni internazionali, ha azione di rivalsa sull’operatore.
La responsabilità sussiste anche per i danni causati sul territorio nazionale da Stati di lancio stranieri: lo Stato italiano è onerato a richiedere il risarcimento allo Stato di lancio nei modi e termini previsti dalle convenzioni internazionali; se decade da tale azione oppure è essa rimasta in tutto o in parte insoddisfatta, i soggetti danneggiati hanno azione di rivalsa diretta sullo Stato italiano (art. 20).
L’art. 22 prevede il Piano nazionale per l’economia dello spazio, avente il contenuto di analisi dei bisogni, direttiva per le iniziative, di scelta per l’allocazione delle risorse pubbliche e anche di promozione della formazione nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).